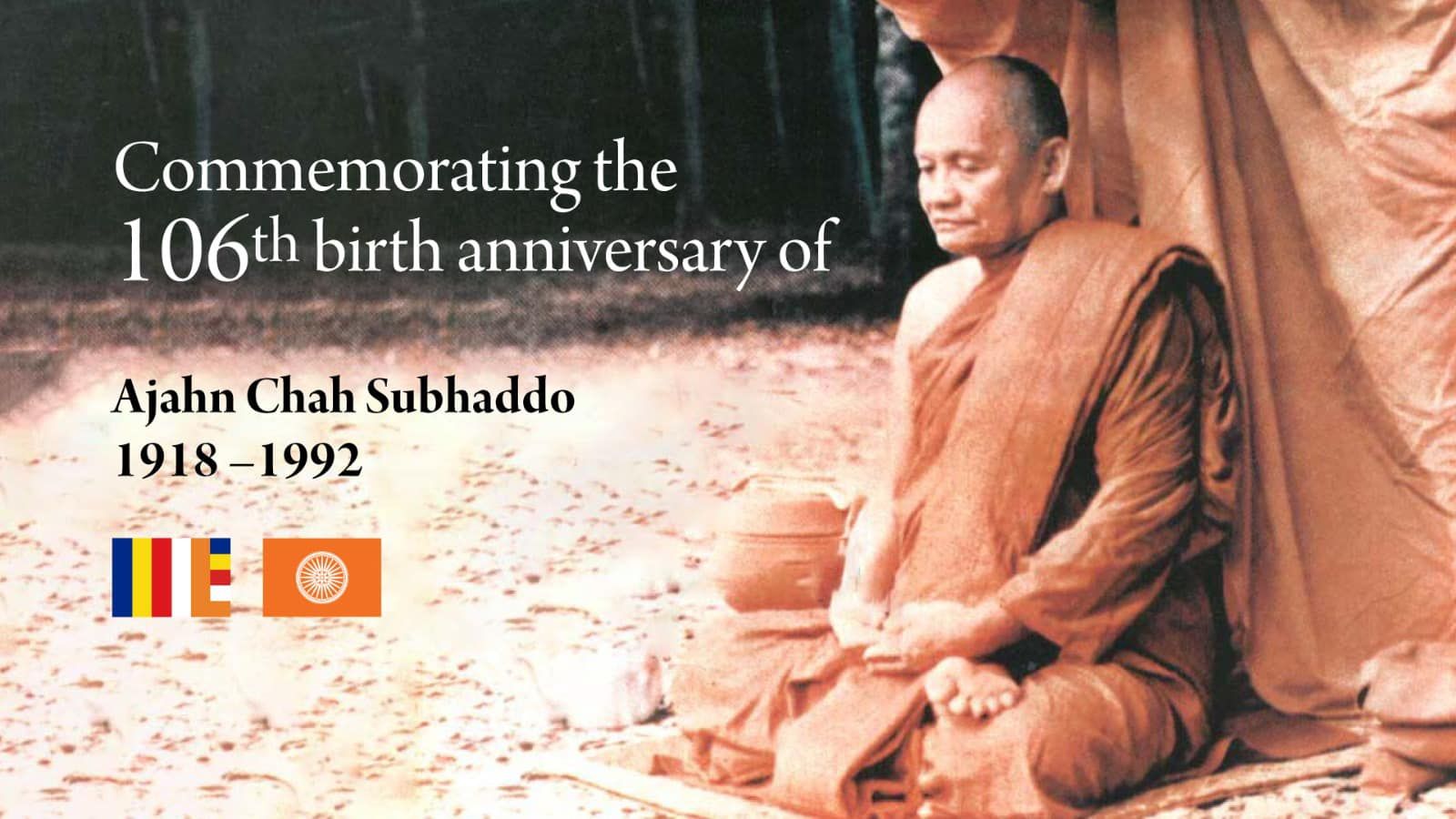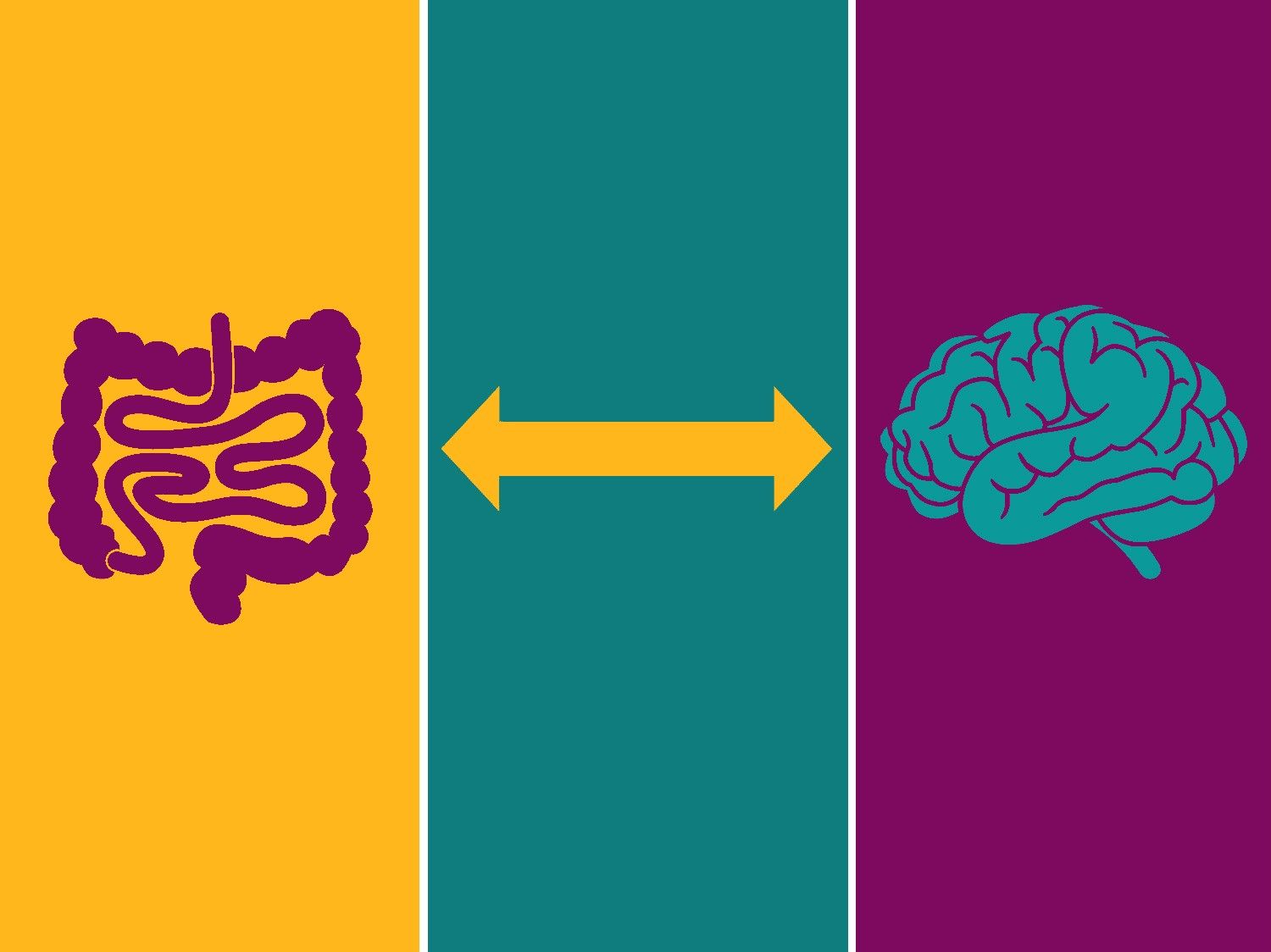La nostra vera casa (consigli a una moribonda) del venerabile Ajahn Chah
Disponiti ad ascoltare il Dhamma con rispetto. Ascoltami con attenzione, come se di fronte a te ci fosse il Buddha in persona. Chiudi gli occhi, mettiti a tuo agio, raccogli la mente e concentrala. Con umiltà, fai spazio nel tuo cuore alla Triplice Gemma della saggezza, della verità e della purezza, per esprimere la tua devozione all’Illuminato.
Non ti ho portato alcun dono materiale; solo il Dhamma, l’insegnamento del Buddha. Rifletti: nemmeno il Buddha, che pure aveva tutte le virtù, poté sottrarsi alla morta fisica. Invecchiò e abbandonò il corpo, deponendo questo pesante fardello. Ora anche tu devi imparare a sentirti paga dei molti anni in cui hai potuto contare sul corpo. Ormai dovrebbero bastarti.
Pensa alle stoviglie che hai usato per tanti anni, tazze, piattini, posate …. quando le hai comprate erano nuove fiammanti, ma ora mostrano i segni dell’uso. Alcune si sono rotte, altre sono sparite, quelle che restano sono consunte, nessuna ha l’aspetto di una volta, perché questa è la loro natura. Anche il tuo corpo è così. Dal giorno della tua nascita ha subito continui cambiamenti, passando dall’infanzia all’adolescenza e infine alla vecchiaia. Accettalo. Il Buddha ha detto che nessuna delle condizioni, mentali, fisiche o esterne, rappresentano il sé: la loro natura è il cambiamento. Contempla questa verità con chiarezza.
Questa massa di carne che giace qui consumandosi è la realtà, è il saccadhamma. La vicenda del corpo è la realtà, è l’eterno insegnamento del Buddha. Il Buddha ci ha insegnato a contemplarla, ad accettarne la natura. Dobbiamo imparare a fare pace con il corpo, in qualunque condizione si trovi. Il Buddha ci ha insegnato a far sì che solo il corpo resti rinchiuso, e a non lasciare che la mente resti imprigionata con lui. Ora che il tuo corpo comincia a cedere agli assalti del tempo, non opporre resistenza; ma non lasciare che la tua mente si deteriori insieme a lui. Mantienila separata. Nutrila con l’esperienza diretta della verità, delle cose così come sono. Il Buddha ha insegnato che la natura del corpo è questa e non può essere altrimenti. Essendo nato, invecchia e si ammala e infine muore. È una grande verità quella che ti si sta rivelando. Osserva il corpo con saggezza e prendine coscienza.
Se la tua casa crolla o prende fuoco, di qualunque calamità si tratti, riguarda solo la casa. Se è travolta da un’inondazione, non lasciare travolgere la mente. Se scoppia un incendio, fa che il fuoco non ti bruci il cuore. È solo la casa che brucia, che si allaga, e la casa è fuori di te. Lascia che la mente abbandoni suoi attaccamenti. È il momento giusto.
Hai vissuto a lungo. I tuoi occhi hanno visto una quantità di forme e di colori, le tue orecchie hanno udito suoni a profusione, hai fatto tante esperienze. Esperienze, appunto, nient’altro. Hai mangiato cibi deliziosi, e tutti quei buoni sapori erano appunto buoni sapori, tutto qui. Quando l’occhio vede una bella forma, di questo si tratta… di una bella forma. Una brutta forma è soltanto una brutta forma. L’orecchio percepisce un suono carezzevole, melodioso, e non è nulla di più che questo. Un suono sgradevole, dissonante, è semplicemente un suono sgradevole.
Il Buddha insegna che nessun essere a questo mondo, ricco o povero, giovane o vecchio, umano o animale, può conservare a lungo il proprio stato. Cambiamento e perdita sono esperienza universali. È una realtà della vita rispetto alla quale non possiamo nulla. Ciò che invece possiamo fare, secondo il Buddha, è contemplare il corpo e la mente per coglierne la natura impersonale, vedere che nessuno dei due è ‘me’ o ‘mio’ ma che la loro è una realtà relativa. Pensa a questa casa: è tua solo sulla carta. Non puoi portartela appresso. Stesso discorso per le ricchezze, i beni e la famiglia: sono tuoi soltanto in teoria. In realtà non appartengono a te, ma alla natura.
Non pensare che questa verità riguardi solo te: siamo tutti nella stessa barca, compresi il Buddha e i suoi discepoli illuminati. L’unica differenza rispetto a noi è che loro accettano le cose per quelle che sono. Sanno che non potrebbero essere altrimenti.
Sicché il Buddha ci ha insegnato a perlustrare attentamente il corpo, dalla piante dei piedi alla cima della testa, e poi a ritroso dalla testa ai piedi. Osserva il corpo. Che cosa vedi? C’è qualcosa che sia intrinsecamente puro? Riesci a scorgere una qualche sostanza permanente? Tutto il corpo è in uno stato di costante degenerazione. Il Buddha ci ha esortato a vedere che non ci appartiene. È normale che il corpo si così, perché tutti i fenomeni condizionati sono soggetti al mutamento. E come potrebbe essere altrimenti? In realtà non c’è nulla di sbagliato nel corpo. La sofferenza non deriva dal corpo, ma da un modo di pensare sbagliato. Quando si vedono le cose in maniera distorta, la confusione è inevitabile.
Pensa a un fiume. L’acqua per sua natura scorre verso il basso, mai al contrario. È la sua natura. Se uno andasse a mettersi sulla riva di un fiume con la pretesa di veder scorrere l’acqua verso l’alto, sarebbe uno sciocco. E questo suo sciocco atteggiamento gli impedirebbe di trovare la sua pace, lì come altrove. La sua opinione infondata, quel suo pensare alla rovescia, lo farebbe soffrire. Se avesse una visione retta, capirebbe che l’acqua scorre inevitabilmente verso il basso e che senza comprendere e accettare questo fatto non può aspettarsi che confusione e frustrazione.
Il fiume che asseconda la pendenza è come il tuo corpo. È stato giovane, è invecchiato, e ora scorre incontro alla morte. Non desiderare che sia diverso, non c’è nulla che tu possa fare. Il Buddha ci esorta a vedere la natura delle cose e quindi a lasciar andare il nostro attaccamento a esse. Prendi rifugio nel lasciar andare. Medita incessantemente, anche se ti senti stanca e senza forze. Lascia che la tua mente si accompagni al respiro. Fai qualche respiro profondo e poi àncora l’attenzione al respiro, aiutandoti con il mantra “Buddho”. Rendi la pratica continua. Più ti senti debole, più la concentrazione dovrebbe essere sottile e accurata, per poter fronteggiare le sensazioni dolorose che emergono. Quando cominci a sentirti stanca, sospendi tutti i pensieri, lascia che la mente si raccolga e poi rivolgiti alla consapevolezza del respiro. Continua a recitare mentalmente “Buddho, Buddho”.
Dimentica le apparenze. Non afferrarti ai pensieri circa i tuoi figli o i parenti, non afferrarti assolutamente a nulla. Lascia andare. Fai che la mente converga su un solo punto e poi lasciala riposare tranquilla nel respiro. Lascia che il respiro diventi il suo unico oggetto. Concentrati fino al punto in cui la mente diventa sempre più sottile, le sensazioni diventano irrilevanti e senti nascere in te uno stato di grande chiarezza e vigilanza. Allora, a poco a poco, qualunque sensazione dolorosa cesserà spontaneamente.
Alla fine, tratterai il respiro come se fosse un parente che è venuto a trovarti. Quando un ospite se ne va, lo accompagniamo sulla soglia per salutarlo. Lo seguiamo con lo sguardo finché imbocca il viale e scompare alla vista, poi rientriamo in casa. Con il respiro facciamo lo stesso. Se è pesante, sappiamo che è pesante; se è sottile, sappiamo che è sottile. A mano a mano che diventa sempre più leggero continuiamo a seguirlo, risvegliando nel contempo la mente. Alla fine il respiro scompare del tutto e non resta altro che una sensazione di vigilanza. È allora che ‘incontriamo il Buddha’. Abbiamo quella consapevolezza limpida e sveglio che chiamiamo ‘Buddho’, il conoscitore, il risvegliato, il luminoso. Questo è incontrare il Buddha, dimorare col Buddha, con saggezza e chiarezza. Il Buddha che è morto è solo quello storico. Il vero Buddha, quel Buddha che è chiara e splendente conoscenza, lo si può vedere e raggiungere ancora oggi. E quando lo raggiungiamo, il cuore è unificato.
Quindi molla la presa, lascia andare tutto, tutto tranne il conoscere. Non farti ingannare dalle immagini e dai suoni che possono emergere in meditazione. Lasciali cadere. Non trattenere assolutamente nulla, resta semplicemente con questa consapevolezza unificata. Non pensare al passato o al futuro, resta dove sei, e raggiungerai quel luogo dove non si avanza, non si torna indietro e non ci si ferma, dove non c’è nulla da afferrare o a cui aggrapparsi. E perché? Perché non c’è l’io, nessun ‘me’ e nessun ‘mio’. Non c’è più nulla. Il Buddha ci ha insegnato a svuotarci così, a non portare nulla con noi… a conoscere, conoscere e lasciare andare.
Realizzare il Dhamma, la via della libertà dal ciclo di nascita e morte, è un’impresa che ognuno deve portare a termini da solo. Quindi persevera nello sforzo di lasciar andare e di comprendere gli insegnamenti. Metti energia nella tua contemplazione. Non preoccuparti dei tuoi cari. In questo momento sono così come sono, in futuro saranno come te. Nessuno può sfuggire a questo destino. Il Buddha ha insegnato a lasciar cadere tutto ciò che è privo di realtà intrinseca. Se lasci cadere tutto vedrai la verità, diversamente non la vedrai. È così che funziona. Ed è lo stesso per tutti. Quindi non aggrapparti a nulla.
Anche se ti scopri a pensare, va bene lo stesso, basta che sia un pensare saggio, e non insensato. Se pensi ai tuoi figli, pensaci con saggezza, non da ignorante. Considera con saggezza qualunque cosa diventi oggetto di attenzione, sii consapevole della sua natura. Conoscere con saggezza significa lasciar andare e non alimentare la sofferenza. La mente è radiosa, gioiosa e serena. Una volta abbandonate le distrazioni, non è più frammentata. In questo momento l’aiuto e il sostegno che ti occorrono puoi averli dal tuo respiro.
È un lavoro che spetta a te e a nessun altro. Lascia che gli altri facciano il loro. Hai il tuo compito, il tuo dovere da compiere, non accollarti quelli che spettano alla tua famiglia. Non farti carico di nient’altro, lascia andare tutto. Lasciar andare calmerà la mente. Adesso la tua unica responsabilità è concentrare la mente e renderla tranquilla. Tutto il resto lascia agli altri. Forme, suoni, odori, sapori… che ne se occupino gli altri. Lasciati tutto alle spalle e fai il tuo lavoro, adempi al tuo dovere. Qualunque cosa emerga nella mente, paura del dolore, paura della morte, preoccupazione per altre persone, sia quel che sia, dille: “Non disturbarmi. Ora non mi interessi più”. Quando vedi emergere quei dhamma, continua semplicemente a ripeterti questo.
Cosa si intende per dhamma? Dhamma è tutto, non c’è nulla che non sia un dhamma. E il ‘mondo’ che cos’è? È esattamente lo stato mentale che ti assilla in questo momento. “Cosa faranno? Chi si prenderà cura di loro quando non ci sarò più? Riusciranno a cavarsela?” Tutto questo non è altro che il mondo. Anche il semplice emergere di un moto di paura rispetto al dolore o alla morte, è mondo. Sbarazzatene! Il mondo è così com’è. Se gli permetti di dominare la tua mente la renderà offuscata e incapace di conoscersi. Quindi, qualunque cosa appaia nella mente, pensa soltanto “Non mi riguarda. È impermanente, insoddisfacente, impersonale”:
Se pensi che vorresti vivere ancora a lungo, soffrirai. Ma anche pensare che sarebbe meglio morire subito o il prima possibile non va bene. È sempre sofferenza, no? Le condizioni non ci appartengono, obbediscono alle leggi di natura. Non puoi fare nulla per cambiare il corpo. Puoi abbellirlo un pochino, renderlo momentaneamente attraente e pulito, come le ragazze che tingono le labbra, e si lasciano crescere le unghie; ma quando arriva la vecchiaia, ci ritroviamo tutti nella stessa barca. Il corpo è così, non è possibile cambiarlo. La mente, invece, possiamo renderla migliore e più bella.
Una casa di legno e mattoni può costruirla chiunque, ma il Buddha ha detto che quella non è la nostra vera casa, è nostra per modo di dire. È casa nostra nel mondo, e obbedisce alle leggi del mondo. La nostra vera casa è la pace interiore. Una casa esterna, materiale, può essere bella, ma non è un vero luogo di pace. C’è sempre qualche preoccupazione, qualche ansia. Perciò quella non è la nostra versa casa, è qualcosa di esterno. Presto o tardi ci toccherà abbandonarla. Non possiamo viverci in eterno perché in realtà non appartiene a noi, appartiene al mondo. Stesso discorso per il corpo. Immaginiamo che sia il nostro ‘io’, che sia me o mio, ma in realtà non è affatto così, è un’altra casa del mondo. Fin dalla nascita il tuo corpo ha fatto il corso naturale; ora è vecchio e malato e non puoi fare nulla per impedirglielo. È così che vanno le cose. Volerle diverse sarebbe sciocco, come pretendere che un’anatra assomigli a un pollo. Prendere atto che è impossibile, che un’anatra è un’anatra e un pollo è un pollo, che un corpo necessariamente invecchia e muore, dona coraggio e forza. Per quanto desideri che il corpo continui a durare, non lo farà.
Il Buddha ha detto: “Aniccā vata sankhārā/ uppāda vaya dhammino/ uppajjitvā nirujjhan’ti/ tesam vūpasamo sukho”. [Formula tradizionale che si recita in occasione delle cerimonie funebri: “Tutte le condizioni, ahimè, sono impermanenti/ sorgono e passano/ essendo nate dovranno morire/ la cessazione delle condizioni porta la pace”]
Il termine sankhārā si riferisce al corpo e alla mente. I sankhārā sono impermanenti e instabili. Appaiono e scompaiono, sorgono e passano, eppure tutti vorrebbero che fossero permanenti. È pura follia. Guarda il respiro. Dopo essere entrato, esce, è la sua natura, è così che dev’essere. L’inspirazione e l’espirazione devono alternarsi, il cambiamento è necessario. L’esistenza delle condizioni si deve al cambiamento, non puoi impedirlo. Rifletti: potresti espirare senza inspirare? Sarebbe piacevole? Potresti fermarti all’inspirazione? Vogliamo che le cose siano permanenti, ma è impossibile. Una volta entrato, il respiro deve uscire. E una volta uscito entra di nuovo; è naturale, no? Essendo nati invecchiamo e moriamo, ed è assolutamente naturale e normale. Il genere umano è sopravvissuto fino a oggi perché le condizioni hanno fatto il loro mestiere, perché inspirazione ed espirazione hanno continuato a darsi il cambio.
Non appena nasciamo moriamo. Nascita e morte sono indissolubili. Pensa a un albero: dove ci sono radici ci sono rami, dove ci sono rami ci sono radici. Sono inseparabili. È curioso vedere quanto cordoglio e angoscia susciti la morte e quanta allegria e contentezza susciti invece la nascita. È pura illusione, nessuno considera i fatti lucidamente. Secondo me, l’occasione più adatta per piangere è quando nasce un bambino. La nascita è morte, la morte è nascita; il tronco è la radice, la radice è il tronco. Se proprio vuoi piangere, piangere per la radice, per la nascita. Rifletti: se non ci fosse nascita non ci sarebbe morte. Capisci?
Non preoccuparti troppo delle circostanze, pensa semplicemente: “Le cose stanno così”. È il tuo unico compito. In questo momento nessuno può aiutarti, famiglia e beni non possono far nulla per te. Adesso solo la pura consapevolezza può esserti di aiuto. Perciò, non esitare. Lascia andare. Liberarti di tutto.
Tanto, se anche non lo fai tu, le cose ti stanno lasciando comunque. Te ne accorgi di come le varie parti del tuo corpo, zitte zitte, se la stanno svignando? I capelli, ad esempio. Da giovane li avevi neri e folti. Ora iniziano a diradarsi. Ti lasciano. I tuoi occhi erano sani e forti ma ora sono deboli e non vedono più tanto bene. Quando ne hanno abbastanza, i vari organi ti salutano e se ne vanno, non abitano qui in pianta stabile. Da bambina avevi i denti sani e robusti, ora tentennano o forse hai la dentiera. Gli occhi, le orecchie, il naso, la lingua, tutto vuole andarsene, perché non è casa sua. È impossibile abitare in pianta stabile nelle condizioni, ci si può solo fermare un poco prima di ripartire. Come un inquilino miope che fa la guardia alla sua casupoletta. Ha i denti malandati, la vista difettosa, acciacchi dappertutto, niente che voglia restare al posto suo.
Perciò, non devi preoccuparti di nulla, perché questa non è la tua vera casa, è solo un riparo provvisorio. Dal momento che sei venuta in questo mondo, rifletti sulla sua natura. Tutto quanto si prepara ad andarsene. Guarda il tuo corpo. Vedi qualcosa che sia ancora com’era prima? La tua pelle è la stessa di un tempo? E i tuoi capelli? Non sono più gli stessi, vero? Dove sono finiti? È la natura, la realtà delle cose. Quando arriva il momento, le condizioni se ne vanno per i fatti loro. A questo mondo non si può fare affidamento su nulla, è un circolo interminabile di agitazione e ansia, di piacere e dolore. Non c’è’ pace.
Quando ci manca una vera casa siamo come viandanti senza meta che vagabondano di luogo in luogo, fra una breve sosta e una nuova partenza. E finché non ritorneremo a casa, quella vera, ci sentiremo smarriti, come chi lascia il paesello natio sapendo che solo al suo ritorno potrà trovare agio e sicurezza.
È impossibile trovare la pace autentica in questo mondo. Non ce l’ha il povero e non ce l’ha il ricco; non ce l’ha adulto e non ce l’ha il bambino; non ce l’ha ignorante e non ce l’ha il professore. Da nessuna parte c’è pace, la natura del mondo è questa. Chi ha poco soffre, chi ha molto soffre lo stesso. Bambini, adulti, vecchi e giovani… soffrono tutti. La sofferenza della vecchiaia, la sofferenza della gioventù, la sofferenza della ricchezza, la sofferenza della povertà… sempre e soltanto sofferenza.
Se osservi la realtà in questa luce vedrai anicca, l’impermanenza, e dukkha, l’insoddisfazione. Perché le cose sono impermanenti e insoddisfacenti? Perché sono anatta, non-io.
Tanto il tuo corpo malato e dolorante quanto la mente che è consapevole della malattia e del dolore si definiscono dhamma. Ciò che è senza forma, come pensieri, sentimenti e percezioni, si definiscono nāmadhamma. Quello che è vittima di acciacchi e dolori si definisce invece rūpadhamma. Materia e non materia sono entrambi dhamma. Sicché viviamo con i dhamma, nei dhamma, e siamo dhamma. Fondamentalmente non esiste alcun ‘io’, ci sono solo dhamma che sorgono e passano continuamente com’è nella loro natura. A ogni istante subiamo nascita e morte. È questa la realtà delle cose.
Quando pensiamo al Buddha, alla verità delle sue parole, sentiamo che è veramente degno di devozione e di rispetto. Ogniqualvolta vediamo la verità, siamo di fronte al suo insegnamento, anche se non abbiamo mai praticato il Dhamma. Però, se ancora non abbiamo visto la verità, quand’anche conoscessimo la dottrina e l’avessimo studiata e praticata, saremmo ancora dei senzatetto.
Cerca di afferrare questo punto. Tutte le persone, tutte le creature viventi, sono sul piede di partenza. Dopo aver vissuto un appropriato periodo di tempo, devono fare il loro corso. Tutti, ricchi, poveri, giovani e vecchi, dovranno affrontare questo cambiamento.
Quando ti rendi conto che la sua natura è questa, il mondo comincia a sembrare privo di attrattiva. Quando ti accorgi che non c’è nulla di intrinsecamente reale su cui fare affidamento, provi un senso di sazietà e di disincanto. Disincanto non significa provare avversione; la mente è limpida e vede che non c’è nulla da fare per rimediare a questo stato di cose, che è semplicemente la natura del mondo. Prenderne coscienza ti permette di lasciar andare l’attaccamento, lasciar andare con una mente che non è né felice né triste ma accetta serenamente le condizioni poiché ne vede saggiamente la natura mutevole. “Anicca vata sankhārā”: tutte le condizioni sono impermanenti.
Per dirla in breve, l’impermanenza è il Buddha. Se vediamo una condizione impermanente per quello che è, scopriamo che è permanente. È permanente nel senso che è soggetto invariabilmente al mutamento. Questa è la permanenza che possiedono gli esseri viventi. C’è una trasformazione continua, dall’infanzia alla vecchiaia, e proprio quella impermanenza, quella tendenza al mutamento, è permanente e invariabile. Se ti metti in questa prospettiva, conoscerai la pace del cuore. È un destino comune a tutti, non riguarda solo te.
Viste in questa luce, le cose perderanno la loro attrattiva e nascerà il disincanto. Il compiacimento per la dimensione sensoriale svanirà. Capirai che possedere molto significa avere molto da lasciarsi alle spalle. Chi ha poco, ha poco da abbandonare. La ricchezza è solo ricchezza, una vita lunga è solo una vita lunga… niente di speciale.
Quello che conta è costruirci una casa come ci ha insegnato il Buddha, costruircela con il metodo che ti ho spiegato. Edifica la tua casa. Lascia andare. Lascia andare finché la mente raggiungerà quella pace che è libera dall’avanzare, dal tornare indietro e dal restare fermi. Il piacere non è la tua casa, il dolore non è la tua casa. Piacere e dolore si consumano e svaniscono.
Il grande Maestro vide che tutte le condizioni sono impermanenti e quindi ci esortò a liberarci dai nostri attaccamenti. Quando arriviamo al termine della nostra vita non abbiamo scelta comunque, non possiamo portare nulla con noi. Perciò, non è meglio mollare tutto prima? È un carico pesante da trasportare, perché non sbarazzarcene subito? A che scopo trascinarcelo appresso? Lascia andare, rilassati, e lasciati accudire dai tuoi familiari.
Chi accudisce gli infermi cresce in bontà e in virtù. Il malato che offre agli altri questa opportunità dovrebbe sforzarsi di non creare complicazioni. Se soffre, se è in difficoltà, lo comunichi apertamente e conservi uno stato mentale positivo. Chi si prende cura dei genitori malati farebbe bene a coltivare premura e gentilezza badando di non cadere nell’avversione. È una buona occasione per ripagare il debito nei loro confronti. Dal giorno della nascita e per tutta l’infanzia fino all’età adulta siete dipesi dai vostri genitori. Il fatto che oggi siate qui si deve alle mille forme di sostegno che vostro padre e vostra madre vi hanno dato. Dovete a entrambi una sconfinata gratitudine.
Dunque mi rivolgo a voi, figli e familiari, che vi trovate riuniti qui quest’oggi: pensate che vostra madre adesso è vostra figlia. Prima eravate figli suoi, ora le fate da madre. Invecchiando, giorno dopo giorno è tornata bambina. La memoria vacilla, la vista è debole, l’udito non proprio perfetto. A volte farfuglia parole incomprensibili. Non prendetela a male. Anche voi che accudite la malata dovete imparare a lasciar andare. Non siate rigidi, lasciatela fare a modo suo. A volte, quando un bambino fa i capricci, i genitori gliela danno vinta per amore del quieto vivere, per farlo contento. Ora vostra madre è come una bambina. Ricordi e percezioni le si accavallano nella testa. A volte confonde i nomi, o vi chiede di portarle una tazza quando magari le serve un piatto. Succede, non prendetela a male.
Dal canto tuo, tieni presente la gentilezza di chi ti accudisce, e sopporta il dolore con pazienza. Allena la mente, non lasciarla dispersa e confusa, e non creare complicazioni a che si prende cura di te. Voi che la accudite, coltivate la virtù e la gentilezza. Non provate ripugnanza per i compiti più ingrati, come ripulirla da muco, catarro, urina e feci. Fate del vostro meglio. Datevi una mano fra voi.
È l’unica madre che avete. Vi ha dato la vita, vi ha fatto da maestra, da medico e da infermiera; è stata tutta per voi. Crescere i figli e assicurare loro un avvenire è il grande merito dei genitori. Ecco perché il Buddha insegnò le virtù di kataññū e katavedī, la capacità di riconoscere il proprio debito di gratitudine e la volontà di ripagarlo. Sono due dhamma complementari. Se i nostri genitori sono indigenti, malati o in difficoltà, faremo del nostro meglio per aiutarli. Questa è kataññū-katavedī, la virtù che fa girare il mondo, che preserva l’unità della famiglia donandole stabilità e armonia.
Oggi, in occasione della tua malattia, ti ho portato il dono del Dhamma. Non ho oggetti materiali da offrirti, quelli che vedo in questa casa sembrano più che sufficienti. Quindi ti offro il Dhamma, un bene il cui valore dura nel tempo, un bene inesauribile. Dopo averlo ricevuto lo puoi spartire con chi vuoi, non si resta mai senza. È la natura della Verità. Sono felici di avere avuto la possibilità di offrirti il dono del Dhamma e spero che ti dia la forza per affrontare il dolore.
Estratto del libro “Il Dhamma vivo”, su gentile concessione dell’Editore Ubaldini.